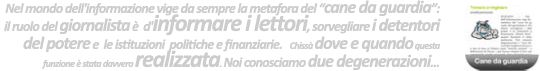Guido Scorza
12.04.2010 – Pubblico, qui di seguito, un primo commento “a caldo” sulle motivazioni della Sentenza Google - Vividown. Si tratta di un’anteprima del pezzo, on line domani sulle pagine di Punto Informatico.
Il Giudice Oscar Magi, nelle “considerazioni finali” che ha ritenuto di aggiungere alla “sua” Sentenza data la “grande (ed inaspettata) ricaduta mediatica” scrive, parafrasando Shakespeare: “too much ado about nothing”.
Il magistrato lo dice ritenendo che con la propria decisione non abbia “alterato in modo sensibile i parametri valutativi e giurisdizionali che presiedono alla decisione di casi quali quello trattato”.
Condivido il richiamo a Shakespeare con il quale il Giudice ha scelto di concludere la propria “fatica” ma in un senso sensibilmente diverso: la Sentenza, infatti, minaccia di produrre uno “scontro tra culture” e rimette in discussione principi di diritto sui quali riposano gran parte delle dinamiche della comunicazione online sulla base di poco più che considerazioni di - peraltro dubbio - buon senso e, in ogni caso, più da buon padre di famiglia e/o da dispensatore di precetti morali che da interprete del diritto.
Ho letto con avidità scientifica e sincera curiosità giuridica le 111 pagine che separano l’intestazione dalla firma del Dr. Magi in calce alla Sentenza, alla ricerca di illuminati ed illuminanti ragionamenti giuridici che giustificassero il verdetto ormai a tutti noto, un verdetto in nome del quale si è scomodata la diplomazia internazionale, si è diviso il mondo politico e si è parlato - più di quanto non accada di norma - di un “Caso Italia” a proposito della libertà di informazione anche in Rete.
Curiosità, avidità e pazienza sono, tuttavia, rimaste frustrate.
E’ difficile rintracciare nella decisione l’enucleazione chiara, puntuale e rigorosa di un solo principio idoneo a sorreggere l’impianto accusatorio ed a motivare la “pesante” decisione adottata dal Tribunale di Milano.
Google Italy, infatti - secondo il Giudice - sarebbe, in buona sostanza, responsabile di violazione della disciplina sulla privacy perché - nell’ambito di un’attività svolta con finalità lucrativa - non avrebbe avvertito in maniera sufficientemente chiara la ragazzina che ha caricato online il video della necessità di prestare attenzione al rispetto della privacy del protagonista - specie perché disabile - del proprio video.
Scrive, infatti, il Giudice a pag. 96 della propria Sentenza che “NON (n.d.r. le maiuscole sono del magistrato) costituisce condotta sufficiente ai fini che le legge impone, ‘nascondere’ le informazioni sugli obblighi derivanti dal rispetto della legge sulla privacy all’interno di ‘condizioni generali di servizio’ il cui contenuto appare spesso incomprensibile, sia per il tenore delle stesse che per le modalità con le quali vengono sottoposte all’accettazione dell’utente” ed aggiunge che “tale comportamento, improntato ad esigenze di minimalismo contrattuale e di scarsa volontà comunicativa, costituisce una specie di ‘precostituzione di alibi’ da parte del soggetto/web e non esclude, quindi, una valutazione negativa della condotta tenuta nei confronti degli utenti”.
Francamente - ed a prescindere da qualsivoglia considerazione giuridica che si fa persino fatica ad intessere in relazione a tale conclusione - trovo tale passaggio, pure determinante, contraddistinto da una buona dose di formalismo giuridico o se preferite “ipocrisia ideologica”: si può davvero ipotizzare che se Google nelle proprie condizioni generali di utilizzo del servizio avesse avvertito, in caratteri più grandi e magari in grassetto, una bambina di dodici anni dell’esigenza di assicurarsi il consenso al trattamento dei dati personali del bambino disabile protagonista del video caricato, questa vi avrebbe provveduto?
E sarebbe bastato così poco - secondo la rigorosa morale del Tribunale di Milano - per risparmiare l’onta di una condanna tanto pesante a quattro superdirigenti di un colosso dell’informazione globale come Google?
E’ curioso - e questo è uno dei tanti profili che mi impongono di definire “piccola, piccola” la Sentenza - che, peraltro, sia lo stesso magistrato, qualche pagina più avanti, nel rigettare la tesi accusatoria che avrebbe voluto Google Italy responsabile anche di concorso in diffamazione, a scrivere testualmente “pur ammettendo per ipotesi che esista un potere giuridico derivante dalla normativa sulla privacy che costituisca l’obbligo giuridico fondante la posizione di garanzia, non vi è chi non veda che tale potere, anche se correttamente utilizzato, certamente non avrebbe potuto ‘impedire l’evento’ diffamatorio. In altre parole anche se l’informativa sulla privacy fosse stata data in modo chiaro e comprensibile all’utente, non può certamente escludersi che l’utente medesimo non avrebbe caricato il file video incriminato, commettendo il reato di diffamazione”.
Difficile seguire la coerenza logica prima ancora che giuridica che lega i due passaggi appena richiamati della Sentenza: mi sfugge probabilmente qualcosa ma, l’impressione, è che a pag. 96 il Giudice abbia ritenuto che se Google avesse dato correttamente l’informativa la ragazzina non avrebbe caricato il video incriminato mentre a pag. 104 si mostri convinto del contrario ovvero che lo avrebbe comunque caricato.
La Sentenza - quella che per settimane ha tenuto banco sui giornali e le televisioni nel mondo intero e che, con ogni probabilità farà altrettanto nei giorni che verranno - è, sostanzialmente, tutta qui.
Inutile cercarvi le risposte ai numerosi e complessi quesiti giuridici che, all’indomani del deposito del dispositivo, avevano appassionato e diviso gli interpreti: è applicabile la legge italiana in materia di Privacy ad un trattamento di dati personali che appare interamente svolto all’estero da un soggetto straniero? Google, in relazione al servizio google-video può essere considerato un intermediario della comunicazione con conseguente applicabilità della disciplina sul commercio elettronico?
Le risposte che il Tribunale di Milano propone - peraltro in modo implicito ed involuto - a tali quesiti appaiono, francamente, deboli, semplicistiche ed approssimative.
Nelle proprie motivazioni il Giudice, infatti, non fa alcun riferimento alla disciplina sul commercio elettronico neppure per escluderne l’applicabilità come, almeno, fatto dall’accusa.
Il magistrato si spinge, invece, a scrivere che poco varrebbe “la distinzione che fanno sia i PM che le difese tra host provider e content provider” quasi a dire che almeno dinanzi alla disciplina sulla privacy intermediari della comunicazione (host provider) e non intermediari (content provider) sarebbero soggetti ai medesimi obblighi e responsabilità e ciò a prescindere da qualsivoglia ragionamento giuridico ma semplicemente perché “non esiste in materia una zona franca” e soprattutto “non esiste nemmeno la ‘sconfinata prateria di internet’ dove tutto è permesso e niente può essere vietato, pena la scomunica mondiale del popolo del web”.
Quanto alla circostanza che Google Italy e non già solo Google Inc. avrebbe trattato in Italia e non negli USA i dati personali oggetto del procedimento, il ragionamento svolto nella Sentenza è, a dir poco, disarmante.
Secondo il Giudice, infatti, la prova che Google Italy sarebbe stata titolare di un trattamento svolto in Italia andrebbe individuata nella circostanza che “attraverso il sistema AdWords ed il riconoscimento di parole chiave” la società “aveva sicuramente la possibilità di collegare, attraverso la creazione di link pubblicitari, le informazioni riguardanti i clienti paganti alle schermate riguardanti Google Video e quindi in qualche modo, gestire, indicizzare, organizzare anche i dati contenuti in quest’ultimo sito” e quindi di trattare “i dati contenuti nel video caricati sulla piattaforma di Google Video” dei quali era “quindi responsabile, perlomeno ai fini del DL sulla privacy”.
Francamente non mi sembra che gestire attraverso un sistema automatizzato come adwords, in forma anonima, l’associazione di contenuti pubblicitari a taluni contenuti audiovisivi ospitati da un soggetto straniero all’estero possa significare trattare, in Italia, dati personali altrui.
Ma, certamente, anche in questo caso c’è qualcosa nel sottile ragionamento giuridico sotteso alla decisione che mi sfugge.
Sin qui il vero contenuto della Sentenza racchiuso nelle sue ultime trenta pagine.
Le sue prime 84 pagine, costituiscono, invece, la testimonianza di un impianto accusatorio che, per fortuna, ha avuto un contributo modesto - se non insussistente - nella decisione assunta dal Tribunale.
La tesi che, infatti, l’accusa sembra essersi sforzata di provare è ancor più dirompente di quanto non sia stata la decisione del Tribunale: Google Italy avrebbe dovuto essere condannata - per diffamazione e violazione della privacy - in quanto costituente una particolare figura di host provider - definito host attivo - fedele alle sole regole del profitto e pronto in nome del perseguimento di tale ignobile (n.d.r. l’aggettivazione è mia ma credo rifletta lo spirito di taluni passaggi delle argomentazioni dell’accusa) obiettivo a non adottare procedure e sistemi informatici di filtraggio pur disponibili al solo scopo di massimizzare la quantità di contenuti - leciti ed illeciti online - e, per questa via, le opportunità di guadagno.
In conclusione, che si fosse innocentisti o colpevolisti, credo che tutti gli addetti ai lavori, da un processo come quello appena conclusosi - almeno in primo grado - si aspettassero qualcosa di più da un punto di vista tecnico giuridico.
Era già difficile accettare che quattro top manager di Big G fossero stati condannati - per un servizio diffuso in 160 Paesi - solo in Italia ma è, oggi, ancor più difficile accettare che ciò è avvenuto in un processo - lo scrivo sotto un profilo tecnico e, lo riconosco, dalla mia facile posizione di osservatore terzo - “povero” di contenuti giuridici e ricco di teoremi, ideologie, senso pratico - peraltro discutibile - e principi da buon padre di famiglia.
Non resta, a questo punto, che confidare nell’appello, non perché dia ragione a Google o piuttosto confermi la Sentenza del Tribunale di Milano ma, piuttosto, perché ripristini, per quanto possibile, quella certezza del diritto che, specialmente nelle questioni della Rete, costituisce un irrinunciabile presupposto per la nascita e lo sviluppo di nuovi modelli di business che per la libertà ed i diritti degli utenti.
Come ho già scritto, oltre a Google c’è di più e, oggi, dopo la Sentenza del Tribunale di Milano, probabilmente, centinaia di operatori - piccoli e grandi - si ritrovano a domandarsi quali siano le regola del diritto che, nel nostro Paese, governano la loro attività.
Qui la divertente ed illuminata “telecronaca” della Sentenza di Vittorio (Zambardino).
[da GBLOG del 12 aprile 2010]
![]()
![]() Argomenti correlati: Internet, Google, Vividown, intermediari, privacy, Net neutrality, UGC, sentenze -
Nessun commento
Argomenti correlati: Internet, Google, Vividown, intermediari, privacy, Net neutrality, UGC, sentenze -
Nessun commento